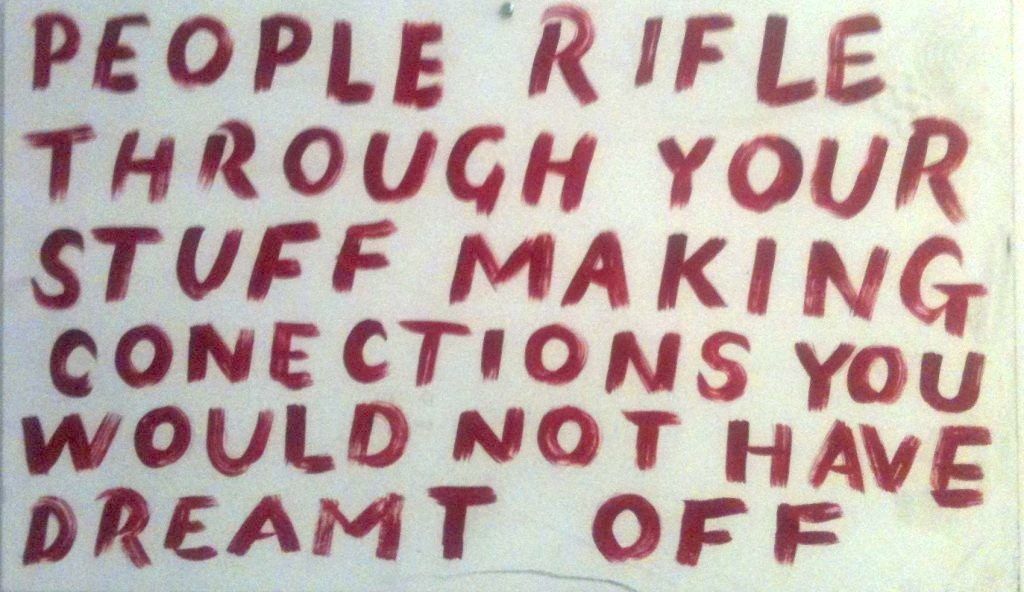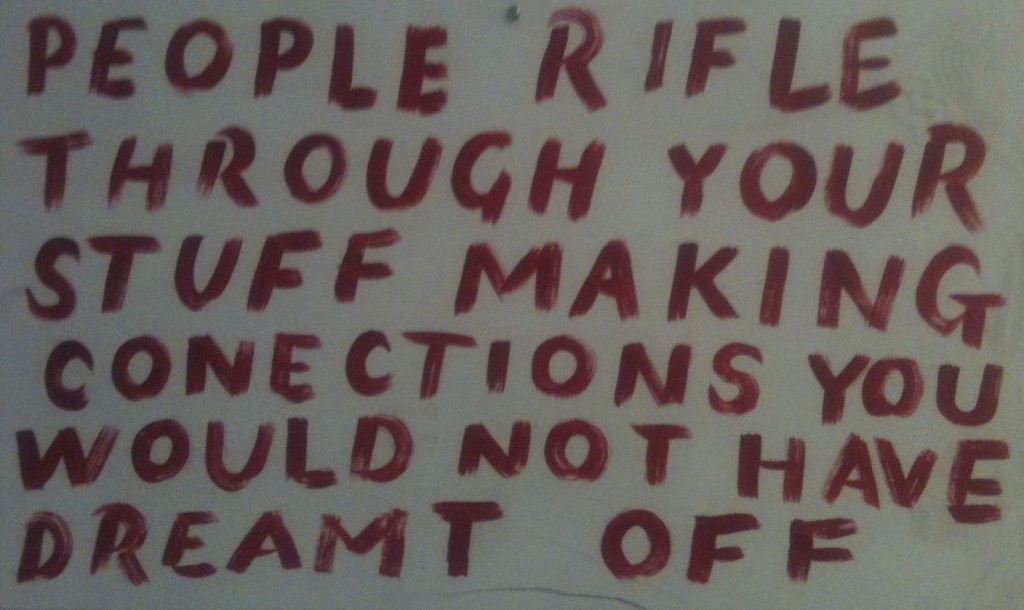“Fondamentalmente sento questo adesso: vale solo la pena di osservare il talento degli altri, e invidiarli – Camilla schiaccia la cicca di sigaretta con la suola contro l’asfalto sbriciolato della piazza – vedere dove io non arrivo, dove io non sono capace. Osservare tutto da molto vicino come la pietra che guarda il diamante. Muta ferma e tutto. Camilla, solo guardare. Non riuscirò a scrivere mai più niente, nemmeno la lista della spesa.”
“E’ un ordine? Un ordine che ti sei data?”. Ne dico una, tanto per dirne una.
“E’ un postulato.”
Quando ti sfugge il termine e hai di fronte Camilla che quasi piange puoi solo far di sì con la testa e riprendere a camminare.
E andare veloce, perché sai che lei hai le gambe corte e t’annaspa dietro.
Sarò impietoso con Camilla, perché la tengo spesso nella vita come si tiene un fratello, o uno più bravo di te, che ti batte sempre e devi nascondere una bastarda soddisfazione quando lo vedi invece che è debole e umano. “La” vedi, dovrei dire “lo” vedo, ribadisco.
Mi convinco a pensarla un uomo, ormai da molto, mi dà sollievo.
La guardo con me e la vedo sola, da sempre. Sola come quando sta in casa per settimane a scrivere soltanto. Uguale.
Sola mentre mi segue con passo indeciso, un vestito troppo leggero per questo bagnato novembre di Napoli e io accelero ancora e ogni tanto mi giro e le chiedo “ti muovi?”. E lei che non s’arrabbia e io che non mi fermo.
Hai voglia a passare il tempo a dirsi di tutto, a provare finanche a scopare per vedere se ci capisci qualcosa: niente. E’ un sasso. E allora mi viene sempre di scagliarla lontano.
Con questo nome da merendina e questa penna poco scaltra che non la porterà da nessuna parte in assoluto.
Camilla di cognome fa Suarez, che mi ricorda un’insegna arrugginita sopra un’officina di Città del Messico. Si muove scattosa in questa forma di dolore che non s’è mai capito cos’è, sempre così la ricordo, da quando aveva diciott’anni e io venti .
Una cosetta arrabbiata, impietosa, indifesa, che ti viene da abbracciarla sempre o di prenderla a schiaffi.
Io non so la forma di male o la forma che il suo male ha preso. Come se avesse un organo che io non conosco, che non so dove sta e che le duole. La vuoi consolare ma non capisci la forma e non potrai mai indovinare quale potrà esserne il sollievo.
E allora divento scontroso e la sfido, le do ragione ad ogni suo alludere alla sconfitta, e ancor più cattivo le dico “hai scelto un mestiere difficile dovevi mettere in conto di fallire”. E un poco lo penso.
Io di queste cose della depressione e tutto non voglio sapere niente. Stai male se ti spezzi una gamba: se mi dici che soffri voglio vedere la ferita, se no stai inventando.
L’unica certezza è che voglio liberarmi di lei e del suo lamentarsi prima che mi rovini la serata, le voglio bene, certo, ma tanto non posso farci niente.
La porto a bere alla Mosca che è ancora deserto, le sfilo il cappotto perché sono galante e ci facciamo portare whiskey e cioccolata, profondamente consolatorio.
Le dico “prendi una rivista di annunci, vai sui siti di lavoro, rimettiti a lavorare nei bar” lei resiste, dice che si è troppo specializzata che ha accumulato scrittura per tutta la vita e questa cosa non fa curriculum. Allora che cazzo vuole. Io con la laurea in Filosofia che lei non ha preso adesso lavoro alla Telecom. Certo sono un capo. Ma Heidegger mi guarda ancora con sospetto.
Lei invece i giornali, i racconti, gli applausi e poi leggere di lei, vederla passare al tg e io in ufficio prima degli altri, con la pioggia e col sole. Ma di che si lamenta. La guardo, bel culo, mentre si appoggia al bancone, si gira, mi vede e ci mette pure un sorriso, la vedo ma lei chi lo sa cosa vede quando, come sempre, come adesso, sta parlando a me.
Ma tanto io questa qua non la voglio.
E lei che non è bella ma c’è sempre qualcuno meglio di me che si innamora, e tutti quegli uomini che si sceglie al posto mio, sempre bellocci e scemi quando l’amavano, sempre mostruosi e cattivi quando lei si innamorava di loro.
Che vengano gli altri a portarle ristoro.
Io mai. Con me soltanto il sesso che si fa con gli amici, peggio di quello matrimoniale, senza nessuna aspettativa o riguardo. E allora perché torni sempre da me, cosa c’è ogni volta da piangere o festeggiare con uno che non ami nemmeno?
Da qui mi sono fatto il conto che Camilla è un uomo, ché se lei è un uomo mi turba di meno. Peraltro Camilla Suarez starebbe benissimo a un trans come nome.
Al cucciolo di carlino di un trans. Io la odio.
Sette volte ci ho fatto l’amore. Vederla nuda, starle dentro, farle male, perché ti viene sempre voglia di farle male, e ogni volta io lì a imprimermi che finalmente stava succedendo per godermela davvero. Era mia e mi chiedevo “resterà?”. Lei invece viene di un bene che è una meraviglia, ci sarebbe da sentirsene orgogliosi finché non ti fa “Mi succede sempre, lo sai? E’ tutto più forte per me, il piacere e il dolore”, ed è una di quelle frasi che ti fa subito posare a terra la coppa della vittoria.
Non era con me che godeva, stava godendo con uno qualunque, come al solito suo, puttana.
L’ho sempre amata e questo va detto e adesso che cosa sono di fronte a lei. Di fronte a questa minuscola preziosa cosa carica di un dolore così vero che io non potrò mai provare.
La guardi come guarderesti un abisso ma è una montagna, e in ogni caso se lei è lì in quelle condizioni adesso, è perché ha fatto qualcosa che tu non hai fatto. Tu non l’hai fatto. Non ti sei lasciato cadere nell’abisso, non hai voluto scalare la montagna, non.
Prendo un altro whiskey per me e per lei, voglio vederla delirare e poi vomitare, vedere fin dove arriva.
Le chiedo il nome di quest’ultimo qui che la strazza d’amore, fa una pausa drammatica, mi guarda attraverso lo specchio del bar, fra le bottiglie e i bicchieri, sospira. Poi si gira, mi guarda davvero negli occhi e sta zitta. Abbasso i miei e lei mi dice “Marco” e io per un attimo m’ero figurato potesse dire “Ma non hai capito? Sei tu, sei tu!” e via musica da pubblicità di cioccolatini o diamanti.
Al terzo whiskey comincia a flirtare col barista, e sì che lo conosciamo da vent’anni, che c’è da sedurre uno così? Ma pure lui, dico, che c’è da sedurre una così mi domando. Non lo vedi quel naso che pare un pirata, che è un naso da uomo, non vedi che è tutta verso di sé disperata per sé soltanto per sé per qualche cosa che non riesce a scrivere, per qualche storia che non riesce a raccontare bene come vorrebbe, come saprebbe, perché lei lo sa fare, dio se lo sa fare e come mi tira dentro ogni volta e come mi ci perdo dai primi ciclostilati dei nostri vent’anni.
“Lascia perdere Camilla, sei in tempo, non ne vale la pena” e non so se è allo scrivere che dico o ai sorrisi cretini a quell’uomo che ci porta altra cioccolata fondente e va via.
“Ma tu ci pensi” mi dice “che potresti morire domani?”
Forse me lo sta augurando. Capisco. Scende dallo sgabello troppo alto per lei, fa un passo e barcolla, dondola su quei tacchi troppo sottili fino alla porta del bagno, ci entra, rimane, ci esce, s’è lavata la faccia, rimessa la matita agli occhi (troppo pesante Camilla, ma non ti rendi conto?) ma è ancora/ ma è già, ubriaca.
La porterei a casa ma io ho la mia donna, che starà già aspettandomi “Ti porterei a casa ma non c’è posto per te” lei risponde un cattivo “lo so” e mi pento perché le ho servito una di quelle battute tragiche che ama tanto.
Voglio andare via. Voglio non averti mai conosciuto. Voglio essere te, stare male come te, voglio non avere i soldi per l’affitto come te, voglio piangere come fai tu, voglio le tue mani piccole tagliate dal freddo, voglio avere paura come ne hai tu, sentire la morte davanti come la senti, toglimi la vita, toglimi la vita e dammi la tua.
Camminiamo di fuori di nuovo nella strada di nuovo veloci, i basoli tutti bagnati dall’umido ché il mare è vicino, assai vicino e si sente.
Lei parla, parla, ride, sono soltanto le dieci di sera ed è già a pezzi, scivola, la raccolgo me la stringo contro la porto in un vicolo di questo lunedì sera freddo e deserto, mi metto sui gradini di questa casa che speriamo non esca nessuno, le alzo la gonna e me la siedo addosso, due mosse per aprirmi la cintura, abbassare la lampo, le entro dentro.
Una mano è alla sua gola e la stringe, com’è facile vederla morire, dirle addio mentre se ne va del tutto, toglierle il fiato e questa volta per sempre, spezzarle il collo, svuotarla di vita, finalmente, lasciarla lì abbandonata, senza voltarmi a guardare, saperla un corpo, un sacco morto, vuoto, in un vicolo sporco, con le braccia da un lato, quelle gambe scomposte, la mutandina blu scivolata alla caviglia sinistra e addio, ma invece già un attimo dopo lei butta la testa all’indietro, si muove veloce, è suo, quel momento è suo, e io no non la uccido e respira forte e si prende il piacere da me e io da lei non mi prendo da la vita.
Battuto. Penso frasi del cazzo come “val bene una messa” e non metto il soggetto e non so poi questa messa cos’è.
Camilla mi abbraccia, dice pure un patetico grazie. Con la scusa che uno s’affaccia, si alza, s’aggiusta, mi dà un bacio in fronte, come ai morti o ai bambini. Va via.
M’ha fregato di nuovo, lo ammetto. Ora io sono triste e distrutto, non ho l’ironia per riderne, la capacità di scriverne, la faccia di pietra per tornare a casa dalla mia donna e guardarla tranquillo negli occhi.
Ora Camilla Suarez, col suo nome da merendina transessuale se ne corre bruttina e confusa a casa, avrà male alle caviglie, dei segni alla gola.
Mi convinco a pensarla un uomo, ancora una volta, mi dà sollievo.
Arriverà in quelle stanze senza riscaldamento e potrà piangere davanti alla sua pagina muta.
Lei non ha chi di lei avrà mai cura.
Io ho tutto quanto invece, non ho lei ma una vita contenta, non ho lei ma una macchina nuova, non ho lei ma la donna più bella, che mi avrà cucinato la carne, il contorno, la pasta, scelto il vino da aprire al rientro.
Non ho lei.