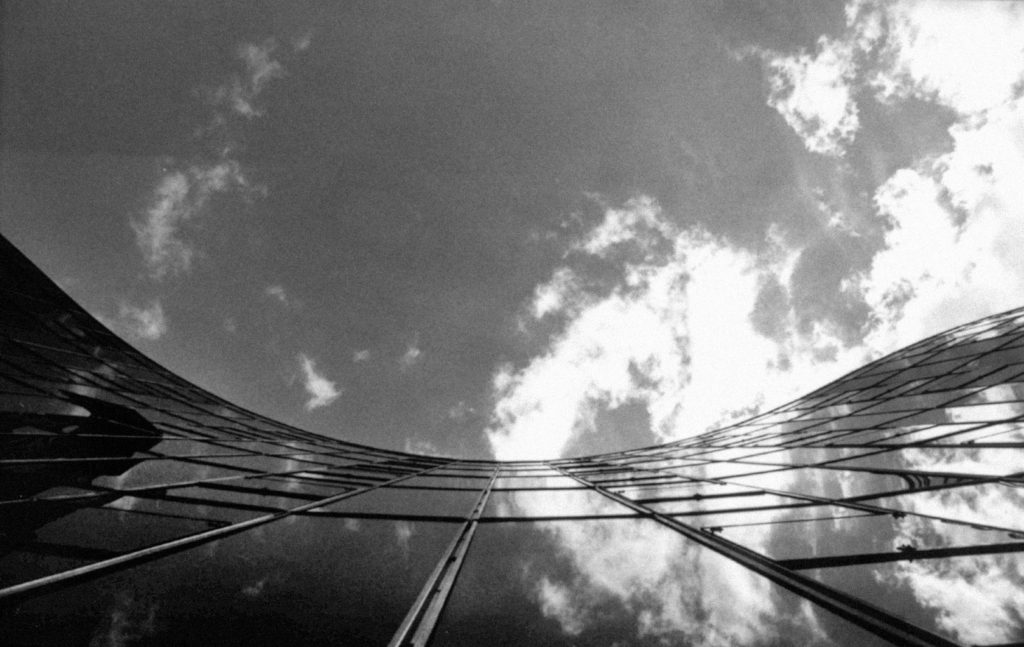LA CASA DEL PARTITO
1.
– Buongiorno, siamo qui per visitare l’edificio.
– Questa è una casa, non un museo. Cosa cercate? Siete iscritti, militanti? Avete la tessera?
– Veramente no… A che tessera si riferisce?
– Alla tessera di partito. Cosa vi interessa?
– Beh, da quel che sappiamo questo edificio è stato progettato da un maestro dell’architettura.
– Sì, ma prima di tutto è una casa, la nostra casa. La “casa dei lavoratori”. Siete compagni?
– Beh, sì… sostenitori. Sosteniamo la causa.
– Bene, allora potete capire. Vedete queste sedie? Questi tavoli? Questi muri? Li abbiamo pagati noi, con i nostri soldi, con i nostri sacrifici e le nostre lotte. Siamo orgogliosi di abitare qui, e il maestro di cui parlate ha condiviso con noi questo spirito. Ha regalato il progetto al partito. Ognuno ci ha messo la sua parte: lui il progetto e noi i soldi per realizzarlo.
Place du Colonel Fabien, XIX Arrondissement, cuore di Belleville. Un tempo quartiere operaio. Era il 1999 e lavoravo a Parigi. Quel giorno, insieme a un amico, mi sono recato là “in pellegrinaggio”, per visitare finalmente – quasi con devozione – la sede del Partito comunista francese, opera stupenda ma stranamente (e inspiegabilmente) poco pubblicata del maestro brasiliano Oscar Niemeyer.
Dalla strada l’edificio si scorgeva appena, nascosto da una cortina di platani. In posizione arretrata rispetto al carrefour, a un primo sguardo sembrava negarsi. Una cancellata – non voluta dal progettista ma imposta in seguito da ragioni di sicurezza – lo separava ulteriormente dal marciapiede, generando una sospensione. Uno spazio in attesa. Ci è voluto un attimo per capire che ciò che si intravedeva all’interno del perimetro recintato annunciava qualcosa di importante.
Era domenica, una bella domenica di settembre a Parigi. La città era semideserta. La sede era aperta. Si poteva entrare senza troppe questioni.
Ci hanno accolto due vecchi camarades. Avevano l’aria stanca. Erano lì per tenere aperta la casa dei lavoratori. Anche la domenica. Non per la giornata del patrimonio, come sarebbe successo dieci anni più tardi. Ma per attività politica. Per difendere ormai l’indifendibile, ritardando semplicemente – senza poterla impedire – l’inesorabile metamorfosi della loro sede da luogo pulsante della partecipazione e della militanza a monumento desacralizzato dell’architettura contemporanea.
2.
La storia di questo edificio – “eroico cantiere dell’Utopia” – è indissolubilmente legata alle vicende internazionali degli anni 60, ai fermenti di rinnovamento e alle nuove istanze politiche e sociali dell’epoca. E inizia nel 1965, quando Oscar Niemeyer, costretto, a causa della sua militanza comunista, a lasciare il Brasile, giunge in Francia come esule politico, in fuga dalla neonata dittatura. In quello stesso anno gli viene commissionato, da parte dell’Esecutivo del Partito Comunista Francese, un primo studio di massima per un nuovo complesso dove concentrare tutte le attività del partito, allora disperse in varie sedi. Gli studi preparatori prenderanno ufficialmente avvio solo nel 1967. Il successivo incarico, affidato allo stesso Niemeyer, vedrà coinvolta, in fase esecutiva, un’equipe di progettisti di grande rilievo: Jean Deroche (suo primo collaboratore a Parigi, a partire dal 1966), Paul Chemetov, José L. Pinho, Jean Prouvé e Jacques Tricot. La realizzazione avverrà in due fasi. I costi sono in larga parte sostenuti dai contributi degli attivisti. Le attività di cantiere si snoderanno su un arco di quasi tre lustri (1967-1980) per terminare con un esito straordinario: un’opera “eretica” in cui si sintetizzano, in modo irripetibile, «il talento creativo del suo ideatore, il magistero costruttivo dei tecnici e delle maestranze e la passione e l’impegno civile di decine di migliaia di militanti».
La complessa forma del lotto su cui sorge l’edificio, un poligono irregolare in leggera pendenza convergente verso il carrefour di Place du Colonel Fabien, viene affrontata da Niemeyer con una strategia progettuale di matrice modernista che interpreta in modo originale e non autoreferenziale l’idea dell’oggetto isolato, rifiutando ogni compromesso con l’impianto urbano ottocentesco di origine haussmanniana che caratterizza il contesto. Il risultato di questa operazione è una composizione rigorosa e dinamica, basata sulla linea curva, sulla giustapposizione dei volumi principali (due “oggetti” collegati da un piano inclinato) e sul contrasto cromatico dei materiali (cemento e vetro): il corpo degli uffici – una manica doppia di sei piani a pianta ondulata – fa da fondale alla cupola bianca di cemento sottile, a sezione pseudoparabolica, che copre l’aula congressi a pianta circolare emergendo parzialmente dal suolo artificiale. Quest’ultimo, raccordando le differenti quote al contorno, funge da copertura del sottostante piano interrato al quale si accede attraverso una fenditura, secondo una modalità tipica dello spazio criptico. L’intercapedine abitabile che si viene a generare costituisce di fatto lo spazio più importante dell’intero complesso, luogo di connessione tra tutte le sue parti, articolato (ma non separato) in spazi secondari tramite setti curvilinei. In esso sono dislocate, in un ribaltamento delle gerarchie spaziali, l’ingresso principale, gli spazi di ricevimento, la libreria, il foyer esposizioni, l’aula del Comitato Centrale e gli spazi per l’attesa, collegati da percorsi in leggera pendenza. Una rivisitazione originale del principio lecorbusieriano del plan libre, dove la purezza formale viene contaminata dal progetto di suolo e i singoli elementi, non più separabili, concorrono alla definizione di uno spazio ibrido e “pulsante”.
Alla purezza formale, chiarezza e “semplicità” dell’impianto esterno – la vetrata continua (mur rideau) dei prospetti, enorme e raffinato serramento progettato da Jean Prouvé per conferire all’edificio il senso di trasparenza della “casa di vetro” (maison de verre), ne delinea la sagoma con grande effetto scenografico –, fa da contrappunto una spazialità interna rivoluzionaria, corporea e fenomenica, costruita attraverso una “strategia percettiva” basata sulla fluidità, che presuppone il movimento e non la contemplazione statica: pensata in questa prospettiva la poesia degli elementi della composizione, l’attenzione ai dettagli, anche i più insignificanti, trasforma gli spazi di distribuzione in spazi veri e propri e rende la transizione da un luogo all’altro un’esperienza totalizzante.
3.
In anni di grandi ubriacature da nuovi formalismi percorrere quegli spazi è stata una lezione di sobrietà non minimalista, di eleganza in equilibrio tra il vetro e il cemento. Dimostrazione della capacità di controllo dell’atto creativo, dell’intuizione e delle moderne tecnologie costruttive, essi incarnano una dimensione visionaria trasformata in materia viva e pulsante, come se il concetto di “uomo nuovo” potesse prendere forma (e acquisire senso) solo attraverso una nuova idea (e una nuova esperienza) dello spazio, a partire dai luoghi dove avrebbe dovuto formarsi la sua coscienza politica. Architettura quindi in quanto simbolo e metafora di un «nuovo modello di società civile ispirato ai principi del progresso, dell’uguaglianza, della solidarietà e della giustizia sociale». Non mero manufatto o semplice insieme di elementi costruttivi. E architettura in quanto casa, nelle intenzioni di progetto così come negli esiti. E, come tale, espressione e testimonianza, racconto di chi la abita. Relazione coerente tra storia e forme. Capace di accoglierne le istanze e dare loro corpo.
Non è un caso che il maestro brasiliano più volte, nel corso della sua carriera, abbia preso le distanze dall’idea di progetto come opera d’arte, dichiarando: «quello che conta non è l’architettura, ma la vita, gli amici e questo mondo ingiusto che dobbiamo cambiare». Il prevalere di una «dimensione sociale e responsabile dell’architettura» testimonia in fondo dell’affinità di pensiero con chi, con la propria militanza politica, i propri sacrifici e il proprio impegno civile, aveva contribuito a costruire la sede del partito. Una casa, la casa dei lavoratori… Per Niemeyer bisogna dare corpo all’utopia suscitando sorpresa e coinvolgimento. Nel contrasto tra l’enfasi sulla «lirica sinuosità delle forme curvilinee» dei resoconti d’architettura e la domesticità dello sguardo dei camarades è racchiusa l’essenza di quel posto.
4.
L’accelerazione della storia determinata dagli eventi del 1989 (quando inizia a calare il sipario sul “Secolo breve”) ha contribuito, come nessun agente fisico sarebbe stato in grado di fare, alla precoce obsolescenza dell’immagine dell’edificio, trasformandolo in testimone di un mondo scomparso solo vent’anni dopo la sua costruzione. Proiettato in una dimensione fantastica, atemporale, in cui la poetica dello spazio si separa dalle sue ragioni fondative, dalla retorica dell’edificio simbolo – mera e ideologica rappresentazione in pietra degli ideali dell’emancipazione –, e le sue forme, ancora potentemente attuali, si rendono autonome dalla connotazione politica che aveva influenzato la loro concezione.
Nonostante ciò il destino dell’opera sembra comunque inseparabile dalla vicenda politica: le difficoltà elettorali e finanziarie del PCF degli ultimi anni hanno infatti determinato la «dismissione parziale e la previsione di una progressiva riconversione funzionale dell’immobile». E se, fino a qualche anno fa, il mantenimento nel tempo della funzione originaria ne aveva garantito «la preservazione, senza manomissione alcuna, dell’integrità morfologica, spaziale e distributiva», oggi, con la crisi di consenso del partito, quelle condizioni sono venute meno. Elemento che, unito a una mutazione epocale del quadro storico, economico e culturale, rappresenta un (ulteriore) fattore di problematicità rispetto alla prospettiva della conservazione, nonostante questo “caposaldo della modernità” il 26 marzo 2007 sia stato iscritto nel classement des Monuments Historiques e sottoposto a vincolo.
Il problema è indubbiamente complesso e, come ricorda Riccardo Forte, storico dell’architettura e studioso del Movimento Moderno, nel caso della sede del PCF come in quello di altre “architetture totemiche” del modernismo, investe questioni di carattere culturale in misura almeno uguale a quelle di ordine tecnico ed economico: «l’epilogo delle avanguardie storiche e il dissolvimento delle ideologie del Novecento impongono oggi la formulazione di nuovi codici interpretativi e di approcci metodologici inediti capaci di misurarsi con le sfide culturali indotte da una società in vertiginosa trasformazione. La conservazione dell’eredità patrimoniale del Moderno e delle sue icone, enclaves de-sacralizzate dell’utopia dottrinaria, non può prescindere dall’acquisizione di un processo di ridefinizione identitaria capace di coniugare le nuove dinamiche economiche e sociali con la lirica espressione creativa – l’assalto al “cielo” della bellezza e della poesia – di cui Oscar Niemeyer è stato un insuperato artefice». Trovare una soluzione, in questo caso, è (anche) un dovere morale.
Paolo Vitali
Questo scritto è la versione ampliata del testo pubblicato dall’autore su “Il Giornale dell’Architettura”, edizione online, 4 maggio 2016″
Immagine di copertina: Lara Favaretto alla 58ma Biennale d’arte di Venezia